|
Numero 15
Feed RSS
Archivio
|
stampa questa pagina [versione printer friendly]

Come se io non ci fossi, Slavenka Draculic, 2000 ed. Rizzoli
1°Edizione : 1999, pubblicato a puntate su Feral Tribune
 Come se io non ci fossi, di Slavenka Drakulic è uno di quei libri che per leggerlo devi avere molto fiato. Come se io non ci fossi, di Slavenka Drakulic è uno di quei libri che per leggerlo devi avere molto fiato.
E questo fiato devi saperlo trattenere, mandarlo giù in gola e custodirlo perché Come se io non ci fossi il fiato te lo toglie.
Drakulic, giornalista e scrittrice Croata, una delle più acute osservatrici del conflitto sui Balcani, ci porta nel mezzo della guerra della ex-Jugoslavia del 1992.
Qui S., protagonista anonima e collettiva, privata dell’identità e quindi potenzialmente ciascuno di noi, partorisce un figlio che non vorrebbe guardare, che non vorrebbe nutrire, per il quale vorrebbe provare indifferenza se non odio.
Dopo il parto, all’interno di un ospedale Stoccolma, attraverso una serie di flashback S. rivive la sua storia di donna bosniaca deportata in un campo di concentramento in Bosnia dove, insieme ad altre donne, subisce anche l’orrore della violenza sessuale da parte dei soldati serbi.
È una storia raccontata con forza tagliente, con la lucidità di una grande giornalista dei nostri (malati) tempi.
È un libro crudele e indispensabile, perché s’insinua nelle nostre menti con ossessione e ci chiama a rispondere a domande che hanno l’amaro sapore delle domande prive di risposte univoche.
Tra i testi di Slavenka Drakulic (Croazia, 1949), in Italia sono stati pubblicati anche: Caffè Europa (1997), Come siamo sopravvissute al comunismo riuscendo persino a ridere (1997), Il gusto di un uomo (1996).
Mirfet Piccolo
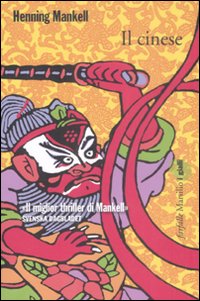 Il cinese, Henning Mankell, 2009 Marsilio Il cinese, Henning Mankell, 2009 Marsilio
Henning Mankell per me è come Bjorn Borg.
Ve lo ricordate lo straordinario tennista svedese capace di vincere 5 Wimbledon consecutivi, dal 1976 al 1980?
Il suo stile era decisamente originale: quel suo rovescio a due mani (per lui la Donnay aveva persino modificato la racchetta, allungando l’impugnatura) faceva inorridire la gran parte dei maestri di tennis, giustamente innamorati del talentuoso rivale John McEnroe.
Ma ciò non impedì a torme di ragazzini di cominciare a emularlo e anzi, soprattutto in Svezia, molti si avvicinarono al tennis proprio grazie alle sue gesta sportive.
Così, ben presto, la nazione scandinava si ritrovò ad avere grandi quantitativi di campioni e a vincere titoli dello slam e coppe Davis a ripetizione.
Questi nuovi tennisti non erano tutti e necessariamente dei cloni di Borg.
Forse all’inizio, ma poi, una volta che il seme aveva attecchito e la scuola si era consolidata, sbocciarono i talenti e arrivò un certo Stefan Edberg, capace di proporre un tennis tra i più eleganti che si siano mai visti e di dar vita ad una sana e avvincente rivalità sportiva con il tedesco Boris Becker.
Ok, mi direte, ma che c’entra Mankell?
Beh, intanto è svedese.
Poi è certamente uno scrittore di successo (noto soprattutto per i romanzi del poliziotto Kurt Wallander) e, come Borg (e in maniera, suppongo, altrettanto involontaria), ha dato il via a una nuova generazione di scrittori svedesi che ormai affollano le nostre librerie (e arricchiscono la Marsilio).
Le analogie non finiscono qui.
La mia ammirazione per Mankell è infatti almeno pari a quella per Borg ma, così come per il tennista, essa non mi impedisce di scorgerne i limiti.
E se, come inventore di storie, egli è senz’altro superiore ai connazionali Leif GW Persson (incapace di creare una vera tensione narrativa) e al troppo convenzionale Stieg Larsson, è indubbio che il nostro esca sconfitto (magari al tie break) da un confronto con i giganti americani del noir (Burke, Connolly, Lansdale…).
Ma chissà, se Il cinese mi fosse piaciuto quanto i suoi precedenti romanzi forse ora non sarei così critico. Probabilmente sarei portato a stemperarne i difetti, a parlare di un carattere svedese (ben diverso da quello americano o mediterraneo) che non può non riflettersi nella letteratura.
Oppure, e legittimamente, mi soffermerei sull’indubbia maestria di Mankell nel raccontare i meccanismi di un’indagine di polizia, di come riesca a fare a meno delle ruffianate di tanta letteratura di genere (molto sangue, un pizzico di sesso, protagonisti bellocci e/o alla moda e soprattutto vincenti, location esotiche…), dosando il minimo indispensabile di colpi di scena e intuizioni geniali (chè senno che noir sarebbe?) e pur tuttavia riuscendo a mantenere vivo l’interesse del lettore mostrandoci, alla fine, come la soluzione del caso sia anche e soprattutto il risultato di un meticoloso lavoro di ricerca, di collegamenti spesso esili e delle molte teorie formulate e poi scartate prima di arrivare a quella giusta.
Questo, dicevo, è ciò che Mankell ci ha regalato in moltissimi dei suoi romanzi.
Il cinese invece delude da ogni punto di vista.
Non convince la scelta di una protagonista donna (la giudice Birgitta Roslin) vista la fatica che l’autore incontra a tratteggiarne il carattere in maniera soddisfacente.
Convince ancor meno la storia, con un movente pretestuoso, qualche incongruenza seminata qua e là e un finale sbrigativo e fondamentalmente irrisolto (concetto ben diverso da quello di aperto).
Ma soprattutto non convince l’ampia parentesi cinese, in cui Mankell fallisce l’esercizio di analisi antropologica e riesce solo a comunicarci il senso di straniamento che colpisce chi si trova improvvisamente a contatto con una società a lui estranea.
Insomma, Il cinese segna una battuta d’arresto nella carriera del nostro svedese.
Forse è presto per parlare di declino.
Forse ha solo bisogno di tempo per affrancarsi dal suo Wallander (senza il quale peraltro aveva già pubblicato il non irresistibile giallo Il ritorno del maestro di danza).
O forse Mankell/Borg è davvero stanco, ma esita a ritirarsi.
Per vanità.
O semplicemente perché ancora non vede, all’orizzonte, un Edberg che ne raccolga l’eredità.
Stiamo a vedere.
Speranzosi e grati.
Giulio Crotti
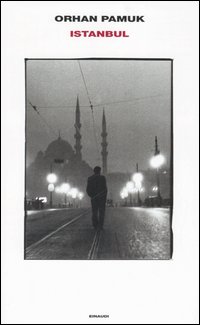 Istanbul, Orhan Pamuk, Einaudi 2006. Istanbul, Orhan Pamuk, Einaudi 2006.
Siete mai stati a Istanbul?
Leggendo il romanzo di O. Pamuk potrete fare una lunga passeggiata attraverso la città sino a spingervi sulle rive del Bosforo per una gita in barca, accompagnati da una guida d’eccezione che ha associato a Istanbul il proprio destino.
Costruendo una trama di ricordi incredibilmente lucidi ed efficaci, l'autore ci parla della sua vita trasmettendoci, attraverso le sue sensazioni, immagini che fanno rivivere i luoghi dove è nato e dove tuttora vive.
Partendo dalla sua infanzia ci narra i primi anni di vita trascorsi con la sua famiglia a "Palazzo Pamuk", offrendoci uno spaccato anni Cinquanta della vita di una famiglia turca spinta verso una sempre più pressante occidentalizzazione.
Da qui l'autore apre le finestre su una Istanbul in bianco e nero e, con la curiosità e l'acutezza che solo i bambini hanno, ci descrive una città in lenta evoluzione, che con fatica cerca di allontanarsi quell'aura di desolazione e decadenza provocate dalla caduta dell'impero ottomano, ma che, nonostante gli sforzi, non riesce a eliminare la tristezza (hüzün in turco) radicata nel sentimento comune dei suoi abitanti.
Camminando insieme a Pamuk adolescente entriamo nelle vie e nei vicoli della città, tra case di legno abbandonate e fatiscenti, simbolo di uno sfarzo ormai dimenticato, affiancate da costruzioni moderne comunque caratterizzate dalle stesse sfumature di grigio che esprimono un sentimento di malinconia tipico di Istanbul.
L'amore che lo scrittore prova per la sua città ci accompagna per tutto il romanzo, ci rapisce con la descrizione dei paesaggi non solo visti, ma da lui vissuti, passando per percorsi quotidiani difficili da catturare come turisti, affascinandoci proprio per l'autenticità della narrazione.
Buona passeggiata.
Elisa Bellodi
|


 Come se io non ci fossi, di Slavenka Drakulic è uno di quei libri che per leggerlo devi avere molto fiato.
Come se io non ci fossi, di Slavenka Drakulic è uno di quei libri che per leggerlo devi avere molto fiato. 


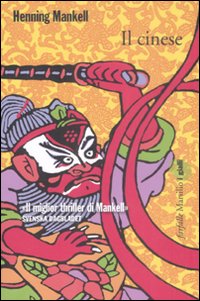 Il cinese, Henning Mankell, 2009 Marsilio
Il cinese, Henning Mankell, 2009 Marsilio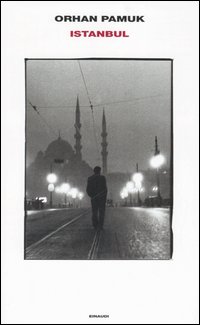 Istanbul, Orhan Pamuk, Einaudi 2006.
Istanbul, Orhan Pamuk, Einaudi 2006.